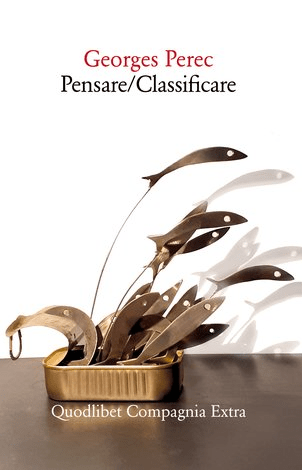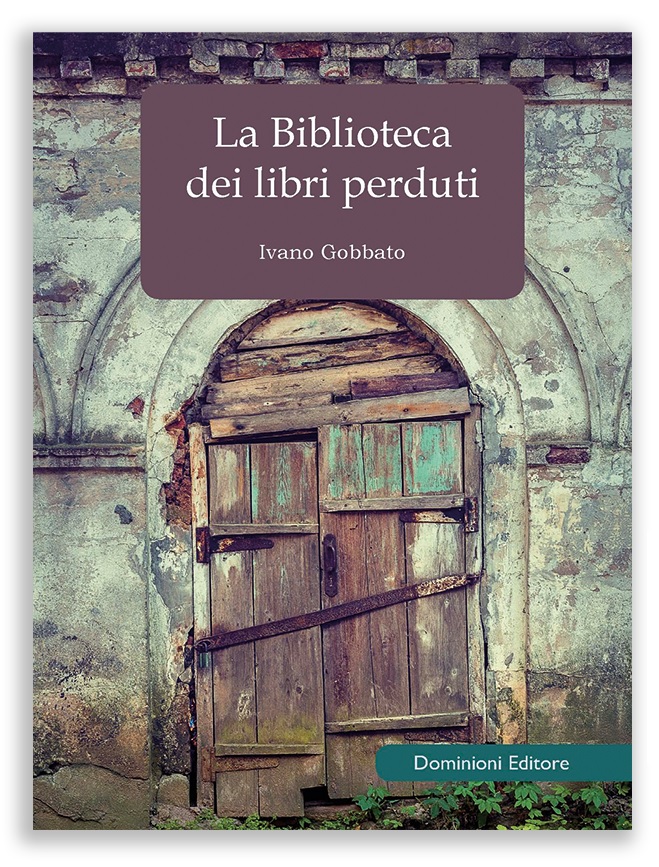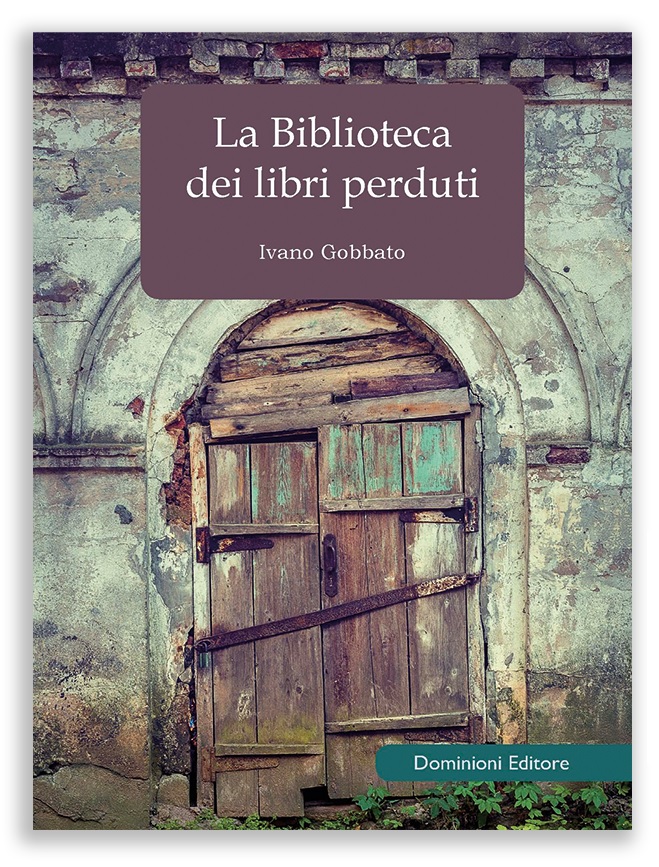Un piccolo libro che parla di grandi amori.
Innanzi tutto per Venezia, decadente e struggente laguna poggiata sul mare e dal mare periodicamente inghiottita e poi rigettata, con l’alta marea preceduta dal suono delle sirene e i veneziani che conoscono i passaggi da attraversare senza le passerelle, vera attrazione per turisti spaesati e conquistati, felici di fotografarsi con stivaloni alti fino alla coscia.
“Venezia è sempre bellissima. … Sarà che è fatta per viverci, che è stata costruita quando il mondo era della misura degli uomini. … Che è democratica, perché ci si va a piedi, tutti quanti, con la stessa pioggia, con lo stesso vento. …Sarà che ti sembra sempre che stia per finire.
Che ti sembra impossibile, che tutta questa bellezza, questa ricchezza possano durare per sempre- Perchè la città è fragile, in pericolo, pare che nessuno lo capisca, che tanti vengono a farle del male, le orde dei turisti che paiono una pompa da giardino sfuggita di mano, l’incuria, il cattivo gusto, i veneziani che la svendono, i negozi con i pesciolini che ti mordicchiano i piedi e quelli che vendono caramelle fluorescenti”.
Venezia che ha la forma di un pesce, che sta sotto e poi riemerge e diventa come una foresta capovolta, con milioni di tronchi che la tengono legata sui fondali, per paura che possa fuggire lontana, senza ritorno.
Venezia amata e vilipesa, Venezia che sa resistere.
L’altro grande amore è per i libri, che sono la vita stessa e quindi debbono essere difesi e salvaguardati, perché sono la nostra identità, la nostra memoria e anche loro, come noi, sono fragili. (A fine testo sono 21 le schede che l’autore scrive per presentarci le librerie della laguna, sorelle della Moby Dick protagonista del racconto e che,come lei, sono state travolte nel novembre del 2019 da un’insospettabile marea di 187 centimetri che ha devastato, travolto e trascinato via centinaia di libri).
Soprattutto quando irrompe l’inondazione.
“Quaranta centimetri in più del previsto. Quaranta centimetri in più cambiano tutto, travolgono letti, spazzano fogli, distruggono provviste, sporcano materassi, e poi calzini, telefoni, gioielli, bicchieri, piatti, stoviglie, libri, centinaia di libri, e adesso non si può fare niente, non si può reagire, non c’è più tempo, né spazio per mettere le cose in salvo, solo stare a guardare, piangere, all’inesorabile bagnarsi, lerciarsi, disfarsi. … L’acqua è inarrestabile, l’acqua non si ferma più, l’acqua si porta via tutto. L’acqua viene ovunque, sgorga dai canali, dai tombini, dai water, dai rubinetti, dal cielo”.
C’è poi l’amore di Vittorio per la sua libreria e per Sofia, giovane studentessa che trova terapeutico soffermarsi a guardare i libri di Vittorio, a sentirne parlare, a farseli consigliare.
Moby Dick è il nome della libreria di Vittorio. “E’ aperta tutti i giorni, anche la domenica. E spesso la luce è accesa fino a sera tardi, perché se Vittorio si mette a leggere non si accorge del tempo che passa … se cerchi un libro che non ha, Vittorio si fa in quattro per procurartelo il prima possibile, e poi ti fa scoprire i libri che non cercavi, quelli che non sapevi di volere … Ha inventato una rassegna di presentazione, la gente riempie il campo fino a tardi per ascoltare poesie, qualche volta organizza un concertino jazz, invita autori italiani a parlare dei loro libri”.
Ma c’è pure l’amore dei veneziani di laguna che non possono non amare Venezia, ormai conoscono i suoi segreti, i capricci dei flussi e riflussi delle maree; si sono attrezzati, sanno come intervenire per mettere in sicurezza le loro mercanzie, sanno interpretare i numeri dei bollettini che scandiscono le ore e i centimetri dove l’acqua tornerà a fare da padrona e Venezia tornerà a essere un pesce.
Ma il giorno dell’inondazione è un giorno diverso e quando finalmente l’acqua torna indietro “Vittorio non si vede. Si è chiuso dentro la Moby Dick. I primi due scaffali sono andati sott’acqua, il terzo è salvo per miracolo … qualche centinaio di libri sono andati perduti, tantissimi, troppi….Ne afferra qualcuno, li apre, li scuote, li sgocciola. … Non c’è niente da fare. Sono da buttare”.
Una vera tragedia, ma l’amore viene in soccorso.
Perchè se la sciagura è di tutti, tutti si sentono chiamati. E’ qualcosa di più del senso civico, è qualcosa di più della condivisione delle perdite, della solidarietà, del salvare il salvabile, della paura della fine per sempre. Quel qualcosa di più è la consapevolezza che siamo tutti fragili. Così fragili.
E allora bisogna darsi da fare. Non perdere tempo. Andare alla ricerca di chi ha meno forze per fare le pulizie, di sgombrare scantinati, di lavare ciò che rimane per evitare che la salsedine continui il lavoro dell’acqua e, quando credi di avere finito, ricominciare da capo.
“Vittorio ha capito che i libri non bisogna metterli ad asciugare sul termosifone. A stare al caldo si increspano, si rovinano ancora di più. Bisogna usare il phon, Aria fredda. Una pagina alla volta. E’ un lavoro infinito, un lavoro frustrante. Lo fa con pochi libri, alcuni che forse può ancora vendere, alcuni a cui tiene particolarmente, che non vuole perdere”.
Braccia, gambe, mani di giovani, vicini, clienti, parroci, commercianti, chi può svolge un lavoro prettamente fisico, chi non può mette mano al portafogli e Moby Dick diventa non solo luogo di sosta e consultazione, ma centro di smercio, di acquisto irrefrenabile, di smania di avere un libro che probabilmente non si leggerà mai.
Poi c’è sempre qualcuno che invece se ne frega, che non dà peso alle tragedie, che mette al centro il proprio benessere e la propria avidità: Vittorio, dopo aver fatto i conti delle perdite, deve misurarsi col raddoppio del canone di affitto della sua libreria, che non può essere contrattato. Si profila davvero la fine, che però non è una fine, perché la vita dopo tutto ci può offrire una svolta e per Vittorio quella svolta ha il nome Sofia, riapparsa dopo giorni e giorni di duro lavoro di pulizie delle calli della città.
C’è anche l’amore dell‘alleato nascosto, quello che in ogni storia sbuca all’improvviso con un colpo di scena.
Pure nella storia del libraio di Venezia c’è qualcuno che dalla sua abitazione ha osservato tutto e che sa tutto: della devastazione dell’inondazione, dell’innamoramento di Vittorio, dell’amore corrisposto segretamente di Sofia che aspetta solo un bacio, della decisione di chiusura della Moby Dick perché non ci si sta più con i conti, di un negozio di merciaia rimasto vuoto quando la vecchia signora Rosalba che fatica a reggersi sulle gambe, si è ritirata dagli affari.
Entra in gioco, traballante ma determinata, la signora Rosalba che spesso abbiamo incontrato fra le pagine, mentre assiste e commenta i fatti del quotidiano che animano il campo su cui affaccia la sua finestra.
Perchè Moby Dick non può morire.
“Benvenuto nella tua nuova libreria … Hai anche una vetrina in più. Il canone non sarà un problema … La cassa potresti lasciarla lì, dove ce l’avevo io…
Vittorio si guarda intorno. Li vede già i suoi scaffali, quelli vecchi, quelli nuovi. Proust, Pamuk Borges, Berto, Dumas, Modiano, Montale, Achmatova, Mann,Pascal, Wells, Montaigne, Auden, Handke, Hastings, Freud, tutti gli altri, sono pronti per migrare da una parte all’altra del campo”.
E’ un racconto prezioso questo del libraio di Venezia, una storia metafora del nostro attuale pezzo di esistenza, per dirlo con le stesse parole di Montanaro:
“Venezia, l’acqua alta e la reazione dei suoi abitanti sono anche il simbolo delle tante emergenze di questo Paese, delle tante impreviste tragedie che continuano a colpirlo ma che, alla fine, non riescono mai ad averla vinta”.