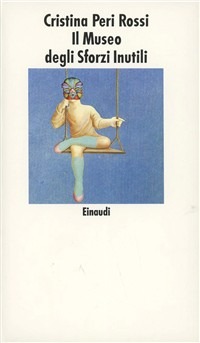Leggo alcune stroncature su questo libro, accusato di voler ripristinare, sia pur velato da poetiche narrazioni, l’antico modello manicomiale.
Pur trovando crudo il capitolo “Legare le persone”, trovo che il testo vada accolto nella sua interezza, con gli opportuni distinguo.
Edoardo, ti ricordi quando lavoravamo alla Salute Mentale?
Facevi una visita domiciliare a uno schizofrenico e ti
ritrovavi a fare:
l’elettricista, il consulente matrimoniale, il medico di famiglia,
il cuoco, l’arredatore,
il personal trainer, l’idraulico, l’amministratore,
il giardiniere, il veterinario, il muratore,
il sarto, la stiratrice, il calzolaio, il postino, l’antennista,
il portinaio, l’assaggiatore, la colì, il maestro del té,
il coloritore, il magazziniere, il carbonaio, il callista,
il buttafuori, il cacciatopi, scarafaggi e l’accalappiacani.
Ti ricordi, Edoardo?
Come ci si divertiva.
Poi ci siamo trasferiti in ospedale, e ci è toccato fare gli
psichiatri.
Questa sottolineatura è di non poco conto per immergersi nelle pagine di chi, dopo aver lavorato in un Centro Salute Mentale, ha prestato servizio in un reparto ospedaliero di Psichiatria d’urgenza dedicando quarant’anni di lavoro alla follia.
In Psichiatria d’urgenza, quella che va accettata
completamente è la persona, non la malattia.
Non parrebbero parole di nostalgia verso quel tempo in cui:
per trovare infermieri, i capisala del manicomio
battevano la porta ai parroci di campagna e facevano
incetta di uomini nerboruti.
Un libro, quello di Milone, scritto totalmente in versi liberi, più simile a uno zibaldone di stati d’animo, sensazioni, paure, sensi di colpa, emozioni che esplorano il “dentro” di una relazione curante/curato che non trascende dal coinvolgimento di Altri (colleghi, studenti, vicini di casa, congiunti, ma anche ambiente e città) e assai lontano da tassonomie, classificazioni di disturbi, strumenti, criteri di diagnostici e di valutazione.
Più che l’affabulazione, ci trovo il desiderio di rivisitare il proprio operato professionale e umano, di creare contiguità tra marginalità e compostezza, di esportare a occhi estranei o costellati di pregiudizi che:
Se non hai mai provato il dolore psichiatrico,
non dire che non esiste.
Ringrazia il Signore e taci.
I matti sono nostri fratelli. La differenza tra noi e loro
è un tiro di dadi riuscito bene
per questo noi stiamo dall’altra parte della scrivania.
In molti dei paragrafi che costituiscono, numerati, affreschi dei singoli capitoli, appaiono frammenti di storie permeate da umanità, dialogo, ascolto, riflessione, quesiti, senza censure davanti anche ai possibili sbagli o fallimenti.
Così è descritto il “transfert”:
Se tu non fossi grave …
se tu non fossi una bipolare …
se io non fossi il tuo curante …
se io ti avessi conosciuta in un negozio, per strada, al mare,
in un altro mondo …
forse …
Chiara, se tu non fossi tu e io non fossi io.
O la tragedia di chi, dopo alti e bassi:
Qualcuno mi ha detto che sei scesa al capolinea e sei
rimasta in piedi sul muraglione.
Qualcuno mi deve aver detto che ti sei incamminata verso
la balaustra e ti sei gettata di sotto.
Un altro l’ha ripetuto: Lucrezia si è gettata di sotto.
Un altro mi ha detto: non prenderla così. Siediti. Hai fatto
tutto il possibile….
Piangiamo Ci arrabbiamo.
Cosa ho fatto di sbagliato? Cosa ho dimenticato di fare?
Nella giostra degli incontri c’è chi transita, chi permane, chi è tossico, chi seducente, chi è etilista, chi aggressivo, chi minaccioso, chi carcerato, chi è demente, chi sfiora la morte, chi ne diventa per sempre amante. Discendere nel girone infernale è un costante misurarsi a tu per tu con le storie di chi, nel proprio dolore, è impegnato con raggiri, manipolazioni, lusinghe, violenze a tenersi in qualche modo aggrappato alla vita.
Fra le pagine, inoltre, si intersecano diversi paesaggi ambientali e umani: i carruggi genovesi in cui è impossibile camminare senza scontrarsi con gli altri passanti, la serenità del mare, le puzze e i profumi, le pontificazioni accademiche, le critiche, le fatiche, l’affaccio delle giovani professioni con i loro tirocini, convinzioni, modi di interpretare i diversi volti della follia.
Mi dici che un paziente agitato e confuso si può calmare
con la parola e il gesto.
Luca, il paziente agitato e confuso non comprende
né parole, né gesto, per definizione.
Tu insisti che lo hai fatto più volte.
Non erano pazienti agitati e confusi.
Ricorrenti le alternative alle analisi descrittive dei sintomi dei disturbi mentali elencati nei manuali diagnostici sempre più voluminosi, certo poetiche e forse poco scientifiche, ma metafore efficaci in cui ognuno di noi potrebbe trovare qualcosa di sua appartenenza:
Se un paziente tiene una mano
sul petto in alto, è un ansioso.
Mano a sinistra sul cuore: Ipocondriaco.
Mano sul petto in basso: depresso.
Mano sull’addome: depresso meno consapevole.
Mano sull’inguine: isterico.
Se invece la mano è sul capo o sulle gambe, sono cavoli:
lì ci vuole uno specialista coi fiocchi.
Un ricoverato giura di aver visto Rufo oggi ai piedi del suo
letto: questa si chiama allucinazione.
La paziente che lo ama giura di averlo visto librarsi in cucina:
questa si chiama visione.
Un Alzheimer giura di avergli parlato poco fa:
questa si chiama confabulazione.
Una paziente privata ha telefonato sperando di trovarlo qui:
questa si chiama illusione.
Giorgio lo schizofrenico dice che è lui al piano di sopra e
ci spia: questo si chiama delirio.
Io stesso ho avuto l’impressione di vederlo un attimo fa in
corridoio: questo si chiama déja-vu.
Prescrivere medicine e andarsene
è come dare bigliettini dell’oroscopo,
come affidare al mare un messaggio in bottiglia.
I depressi soffrono per colpa, il loro è un problema morale,
non capiscono a cosa servano le medicine.
I maniacali stanno bene come stanno e non vogliono
medicine deprimenti.
Gli schizofrenici sono affezionati alle loro voci e non
capiscono neanche chi tu sia.
I paranoici sono convinti che tu voglia avvelenarli.
I caratteriali ingurgitano tutto il flacone la sera stessa.
I nevrotici sono gli unici che leggono le ricette e le seguono
pedissequamente, fino al primo effetto collaterale,
poi non le vogliono più.
Nel capitolo più controverso e dibattuto “Legare le persone” sono contenute le crude descrizioni militaresche delle pratiche esercitate, nonché le situazioni in cui vengono applicate. Siamo nella Psichiatria d’urgenza e non ci si può permetterti di filosofare sui massimi sistemi e sulla loro mancanza: devi agire con chi ti trovi davanti, spesso lì condotto anche attraverso Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Sono andato a un seminario sulle contenzioni.
Un collega dice quante ne ha fatte nella sua vita:
sono quante ne faccio io in un anno.
Perchè facciamo tante contenzioni in Reparto 77?
Siamo così cattivi? Siamo così incapaci?
Il metodo più semplice per non legare nessuno,
è non ricoverare pazienti da legare.
Se non si ricoverano etilisti, caratteriali, tossicodipendenti,
psicoorganici, dementi, intossicati, violenti in genere,
cosa resta da legare al letto? Gli infermieri tra di loro.
Basta rifiutare i pazienti agitati e confusi
e trasformare la Psichiatria in Psicologia.
I pazienti agitati, li legheranno altri.
Conosco l’argomento e figuriamoci se non approvo l’eliminazione della contenzione.
Ma ci sono situazioni in cui il tempo dell’ascolto è impossibile, pena l’incolumità del paziente e di altri; ci sono situazioni in cui è il paziente che ti chiede
il riunire frammenti spezzati tra loro,
mettere insieme mente e corpo, riunificare la persona,
come un gesso rinsalda le ossa.
Far di pezzi, uno.
Se non c’è il legare, non immagino la sedazione farmacologica come qualcosa di migliore.
E ci sono poi situazioni, quelle sì che fanno ribollire il sangue, in cui l’unico modo, forse, per evitare di ricorrere a tale strumento è la possibilità di avere i mezzi indispensabili: personale, servizi, reti, politiche sanitarie e sociali. Perchè siamo tutti convinti che prevenire è meglio che curare e siamo tutti bravi a dire che cosa non funziona quando il caso esplode fra le mani.
In questo capitolo io ci ho letto i casi limite, mentre in moltissime altre parti ho trovato empatia, comprensione, speranza, disillusione, voglia di proseguire nonostante. Insomma quell’”Arte di legare” dai molteplici significati, a partire dall’immagine di copertina che mostra due mani che cingono una vita.
Signori, lo dico chiaro: io non so nulla di interpretazione
dei sogni. Non è il mio mestiere.
I miei pazienti non parlano dei loro sogni notturni:
ci vivono dentro.
Io non cerco interpretazioni: ho bisogno di una corda per
tirarli fuori.