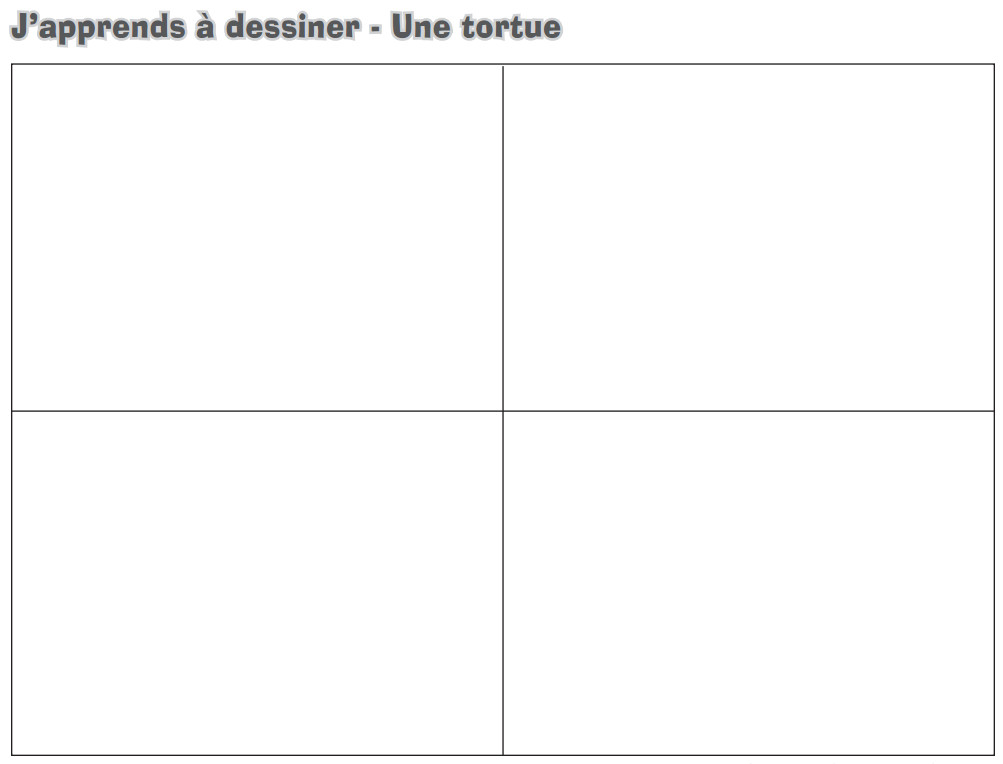Su un’isola deserta, la vita di un naufrago è scandita da misteriose apparizioni di una splendida tartaruga rossa, creatura dell’oceano imponente e rispettata. Un animale solitario e pacifico per definizione, portatore di irresistibile fascino e mistero: per lunghi periodi, infatti, scompare nell’immensità dell’oceano. Numerosi, inoltre, i racconti di unioni tra esseri umani e animali nella cultura giapponese: persino la nonna del primo imperatore, narra la leggenda, aveva le sembianze di uno squalo.
ABBR. E OVVERO “L’ANATEMA DELLA PAROLA”

E’ giunto il momento di metterci un punto. Nel senso del punto fermo, quello che chiude un periodo prima di passare ad altro argomento.
Non il punto che non è seguito dalla maiuscola, che non richiede di inserire uno spazio, che gioca ad alternarsi fra singole lettere. Odio quel tipo di punto.
Attenta alla mia stessa essenza e brucia ogni mia libertà.
Potrò, finalmente, dar voce ai miei diritti? Di esistere, di allungarmi, di estendermi, di stiracchiarmi, di dispiegarmi, di srotolarmi nelle mie diverse lunghezze senza dover più incespicare nei punti che mi (s)troncano o sentirmi contratta in un’accozzaglia dura e impronunciabile di consonanti troppo promiscue?
Senza dovermi scervellare per capire se s.s. sta per strada statale, sua santità o Schutz-staffein; se p.s sta per pubblica sicurezza, post-scriptum o previdenza sociale, se a.c. sta per anno corrente, avanti Cristo o assegno circolare?
Basta. Reclamo il ritorno e la vicinanza degli amici virgola e punto e virgola, del punto esclamativo e di quello interrogativo, i buoni, vecchi e cari segni di interpunzione utili a regolare il mio suono e quello delle mie sorelle che con me costruiscono il senso delle frasi, del discorso, del linguaggio.
Voglio ritornare a essere tutta, intera, globale e illimitata.
Esigo la rotondità della a e della o, l’esilità della i, l’occhiello della e, la pervietà della u.
Pretendo il mio potere definitorio e la chiarezza di ciò che esprimo, senza ricorrere a barbarismi, sigle o acronimi che deturpano il valore del mio sussistere.
Basta una volta per tutte all’osceno utilizzo delle parentesi, quelle che un tempo racchiudevano i puntini di sospensione atti a segnalare, per citare un esempio, l’omissione di un passo all’interno di una citazione.
Da quando sono arrivate le insulse faccine che presumono di raffigurare le espressioni facciali umane, le sagge parentesi sono diventate rappresentanti di sensazione emotiva, anteposte o postposte ai due punti, ai trattini, a singole lettere alfabetiche o apostrofi.
:’-) piango amaramente. No, anzi, macché 😦 sono proprio contrariata.
Cedere il passo a segni grafici per raccontare l’inesauribile gamma delle emozioni?
S’, proprio loro, le emozioni, vita e colore della nostra esistenza, così inattese e impreviste, fugaci e mutevoli nelle loro variabili sfumature, fonti di impaccio o di ispirazione sia negli abissi della disperazione che nelle vertigini della speranza.
ç_ç per dire triste? E come la mettiamo con le diverse varianti della tristezza? Come disegniamo parole come pena, dolore, cupezza, malinconia, autocommiserazione, afflizione?
E’ solo la parola che dipinge, rischiara, rabbuia, intensifica, indebolisce, accentua, attenua, spiega e interpreta la complessità degli eventi e dei vissuti.
E non mi vengano a raccontare che le emoticon hanno rivoluzionato il modo di scrivere e di comunicare, solo perché hanno l’obiettivo di raggiungere l’empatia del faccia a faccia nelle tastiere informatiche.
Non mi si dica, per favore, che i nativi digitali sanno andare dritti al cuore , senza dilungarsi in sorpassate sfumature lessicali e semantiche.
Solo io, la parola, posso raccontare.
Solo io, la parola, posso rivelare.
Solo io, la parola, posso essere parlata o scritta.
Solo io, la parola, nel momento in cui sono detta, letta o scritta, divento creatura vivente, pulsante, eterna.
Senza interruzioni, senza blocchi, senza annullare l’attesa.
Mi amo. Forse sono egocentrica, o forse un po’ senile. Vivo nel rimpianto delle tavolette di cera, dei rotoli di papiro, dei fogli di carta.
Sono vecchia, ma non voglio morire.
Gioca con me, uomo, e condividi la mia protesta. Urlami:
“Ti guardo con riguardo”.
“Dò un senso al tuo dissenso”.
“Mi gusto il tuo disgusto”.
“Fiuto il tuo rifiuto”.
Riprenditi la parola, per favore. Fammi ancora sentire unica, insostituibile, preziosa.
Perché finché ci sono io, ci sarai anche tu.
Indissolubilmente uniti prima che il tuo cervello diventi un definitivo ammasso di neurochip.
Scampato pericolo
Le lancette della sveglia segnavano le quattro e trentacinque. Non così presto e, forse, nemmeno così tardi per dire “Vado”.
Una debolissima luce filtrava tra le strisce delle tapparelle, più occupate a resistere alle estenuanti raffiche del vento che preoccupate a seguire il percorso del sole.
Il rumore era infernale in quell’albeggiare tardo primaverile e le parole “Speriamo che la brace si sia spenta”, pronunciate da Laura nel dormiveglia, erano state sufficienti a innescare il pensiero paranoico di Federico.
Una frase di per sé innocua, ma proprio perché apparentemente tale senz’altro occultava un potenziale pericolo. Federico ripassava le parole ad una ad una: speriamo (confidare in un esito favorevole di qualcosa); brace (legna che arde senza sprigionare fiamma); spenta (che non è accesa). E più il vento soffiava e più la ripetizione di quelle singole parole assumeva forme cupe e distorte.
La brace prendeva corpo e danzava liberata dal vento; decine di piccoli tizzoni si svegliavano dal torpore e, alimentati dall’ossigeno, davano vita a un vortice di esili lingue fiammeggianti che, l’una appresso all’altra, si rincorrevano nell’arida vegetazione circostante.
“Vado”.
La strada era quasi deserta. Se non fosse stato per quel pensiero martellante della brace, sarebbe stato sociologicamente interessante analizzare il passaggio dei pochi mezzi nella penombra del giorno che voleva arrivare.
Sul breve percorso che dalla casa di città conduceva alla residenza lacustre il traffico era ancora addormentato: il furgoncino della Centrale del Latte, il camion della raccolta dei rifiuti differenziati, qualche auto di probabili lavoratori turnisti.
Dietro il profilo dei monti lentamente si stagliava una luce che solo Rohmer avrebbe potuto romanticamente definire “raggio verde”. In realtà gli occhi di Federico assistevano all’innalzamento di mulinelli ardenti, lingue arroventate e colonne infuocate il cui fumo, a contatto con l’umidità dell’aria, spargeva raggi rossi in ogni direzione del cielo.
Il piede schiacciò nervosamente l’acceleratore, come se l’aumento della velocità potesse frenare l’avanzamento delle fiamme che sicuramente, adesso, avevano superato il contenitore di latta adibito alla bruciatura delle fascine, varcato il confine de del giardino, aggredito gli alti cedri del libano, arso completamente il secco sottobosco della tenuta dei Rossi e, infine, allertato il pigro risveglio degli ignari paesani, più inclini all’aroma del caffè del bar del borgo, che all’acre odore del devastante incendio.
Quando la macchina si arrestò nel parcheggio, Federico, tutto sudato, cercò le tracce di quel che sopravviveva, mentre l’ossessiva ideazione ora era rivolta alle sicure denunce, al risarcimento degli ingenti danni, al pignoramento dei beni, a un futuro sul lastrico e, chissà, forse anche alla carcerazione per l’accusa di incendio doloso.
In realtà non era successo proprio niente. Una brezza amichevole annunciava un cielo terso e privo di angoscianti spettri color porpora. La brace giaceva grigia, ancora umida dopo le secchiate d’acqua che Federico non mancava mai di gettare sul residuo di fuoco prima di tornare in città.
Le cinque e quaranta. Il tempo per rincasare e ritornare nel tepore del letto, dove Laura, al contrario, si apprestava all’inizio della giornata.
“Tutto a posto”.
“Tutto a posto cosa?”
“Niente, niente”.
Pessima consigliera, la paranoia.
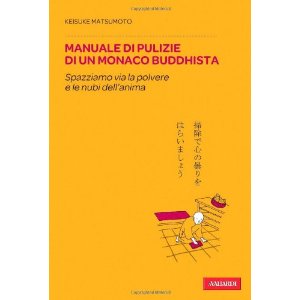
TartaRugosa ha letto e scritto di: Keisuke Matsumoto (2012), Manuale di pulizie di un monaco buddhista. Spazziamo via la polvere e le nubi dell’anima, Antonio Vallardi Editore, Milano (traduzione di Ramona Ponzini)
TartaRugosa ha letto e scritto di:
Keisuke Matsumoto (2012)
Manuale di pulizie di un monaco buddhista
Spazziamo via la polvere e le nubi dell’anima
Antonio Vallardi Editore, Milano
(traduzione di Ramona Ponzini)
Sul lato del pensiero musicale, nel 2007 la mia grande novità è stato poter essere invitato su Insensatez di Kosmogabri Chickasaw. Ed è al primo posto.
Poi arriva il resto, con mescolanza fra vecchio e nuovo, come si addice al mio status cronologico.
Leggendo questo libro ho scoperto qualche mio tratto buddista. Forse.
Non sono una maniaca delle pulizie, però ho ben chiari certi miei comportamenti rispetto ad esse, le cause che li scatenano e gli effetti che ne derivano. Sicuramente Matsumoto mi ha fatto più volte rispecchiare in alcune affermazioni.
Purtroppo sono ancora ben distante dallo Zengosaidan, ovvero “non pentirti di ciò che hai fatto in passato, non preoccuparti per il futuro e dedicati con tutte le tue forze a non avere mai rimpianti”.
Mi riconosco abbastanza in ciò che invece lo scostamento da questa filosofia comporta, come spiega l’autore: “Credo che le persone che vivono nella società contemporanea, sempre così indaffarate, arrivino a casa stanche, lascino i piatti sporchi nel lavandino, i vestiti nel cesto del bucato e poi si addormentino. La mattina seguente, però, si sveglieranno freschi e riposati? Non è più probabile che si sveglino tristi perché salutano il nuovo giorno circondati da tutte le cose lasciate in disordine la sera prima?”
Mmmh …
La casa in disordine effettivamente mi inquieta e la tendenza a non trascurare almeno bagno e cucina con annessi e connessi, più il rifacimento del letto prima di uscire sono senz’altro attività che mi fanno guardare alla giornata con un senso di maggior leggerezza.
Non c’è luogo come il bagno che sveli il vero volto di una casa. … L’acqua è il fondamento della vita. In una casa normale l’acqua si trova in cucina e in bagno. L’acqua entra nel nostro corpo, circola e poi viene espulsa, ritornando alla natura. Le pulizie di cucina e bagno sono basilari nelle pratiche religiose proprio perché siamo coscienti del fatto che sono i luoghi dove scorre l’acqua…. In qualsiasi tempio buddhista il bagno è sempre pulitissimo e davanti alla porta si troveranno le calzature sistemate con cura. Anche il gabinetto trasmette un senso di pulito e questo fa sì che vi si possano espletare le correlate funzioni con animo sereno. Sicchè, chi ha finito di utilizzarlo, dovendo fare in modo di non turbare tale atmosfera a scapito di chi vi entrerà in seguito, si preoccuperà di lasciare tutto pulito e in ordine.
Ho inoltre dato una spiegazione al perché i vetri sporchi mi turbano e mi danno la sensazione di essere immersa nello sporco:
Il vetro è simbolo di trasparenza e di non attaccamento alle cose terrene. Se nei giorni nuvolosi i vetri delle finestre sono coperti di ditate, anche la nostra anima si rannuvolerà. Nel buddhismo la cosiddetta “giusta visione”, ossia il vedere attraverso il filtro di noi stessi, il nostro io, sconfigge ogni nube e permette di comprendere la vera essenza delle cose. … Le finestre sono, dunque, in qualche modo legate alla giusta visione delle cose e pulirle fino a farle sembrare trasparenti, fino, cioè, a farci dimenticare della loro esistenza, ci permette di vedere dall’altra parte senza renderci conto che c’è qualcosa che ci separa. Puliamole, dunque, fino a far sparire ogni ombra.
Vorrei essere un po’ più monaca, a questo riguardo, e utilizzare le raccomandazioni sul come effettuare le pulizie del vetro: è essenziale la carta del giornale. Bisogna utilizzare carta di grandezza commisurata a quella del vetro da pulire, imbevuta della giusta quantità di acqua e detergente, e lucidare a fondo. .. Bisogna prima togliere le macchie più evidenti con movimenti verticali e orizzontale, fino a finire la miscela di acqua e detergente .. suggerisco di mescolare aceto e acqua insaponata.
Nel testo sono parecchie le indicazioni date sia sul come eseguire le pulizie, sia su quali strumenti utilizzare. Sui pavimenti ho ancora molto da imparare:
I pavimenti vengono puliti ogni giorno, indipendentemente dal fatto che siano sporchi. Grazie a questo tipo di pulizie anche il nostro spirito si manterrà lucente…. Lucidare i pavimenti tutti i giorni vi permette di capire cosa significa realmente pulire la vostra anima. Una stanza sporca e in disordine è segno che anche il vostro spirito è sporco e in disordine.
Però mi consola verificare che sul “come lucidare i pavimenti” sono abbastanza a buon punto:
Per prima cosa bisogna passare la scopa e togliere la polvere, poi si prendono un secchio colmo d’acqua, uno straccio ben strizzato e si pulisce a fondo. Non sono necessari detergenti né stracci per asciugare. Poiché uno straccio ben strizzato trattiene l’acqua, una volta passato sul pavimento quest’ultimo si asciugherà da sé. .. Quando lucidiamo un pavimento non distraiamoci e concentriamoci su ciò che stiamo facendo, con naturalezza ci troveremo faccia a faccia con la nostra anima.
Ecco, guardando anche l’illustrazione dove si vede il monaco diligentemente a carponi che strofina il pavimento, debbo dire che io pure assumo quella posa, a dispetto di tutti gli elettrodomestici in commercio da me giudicati non all’altezza dell’antico olio di gomito, accompagnato dalla modernità di un panno in microfibre che un’amica mi ha suggerito e che, immerso e strizzato nell’acqua bollente, effettivamente ti fa rispecchiare nelle piastrelle.
Comunque l’insegnamento è impari: i monaci vivono nel tempio e non hanno tre gatti che girano per casa, oltre a TartaRugoso.
Sullo stirare temo non ci siano possibilità di recupero:
Anche noi monaci indossiamo l’abito monacale dopo averlo stirato. Così facendo il nostro spirito sarà ben curato e in armonia con il nostro vestiario. Le grinze, inoltre, rimandano la mente alla vecchiaia, sebbene ci siano monaci che continuano a svolgere in maniera ineccepibile le proprie attività anche a ottanta o novant’anni, in perfetta salute. … Stirare è l’attività ideale per chi vuole mantenere giovane il proprio spirito.
Si sente che l’autore è ancora nell’età in cui si pensa che le grinze possano essere ripassate facilmente come con il ferro da stiro!
Molti sono i suggerimenti pratici per chi si voglia avvicinare a meditazioni filosofiche e spirituali attraverso il fare le pulizie.
Chissà se riuscirò prima o poi ad arrivare alla seguente conquista:
Ogni cosa sta dove deve stare. Può sembrare ovvio, ma se si applica concretamente questo principio, non si correrà più il rischio di imbattersi in qualcosa fuori posto. Quando dobbiamo utilizzare un oggetto lo prendiamo dal luogo dove è collocato, ma una volta usato lo rimettiamo dov’era. … Sentire la voce delle cose. Lo spirito non va mai tenuto in una condizione di trascuratezza. Se usate le cose con cura, inizierete a sentire bisbigli all’orecchio dello spirito e sarete in grado di udire la loro stessa voce. Al contempo, è necessario conoscere a fondo lo spazio di sistemazione, ossia la stanza va percepita come se fosse una parte del nostro corpo e va pulita ripetutamente giorno dopo giorno. Capire l’essenza degli oggetti e avere dimestichezza con lo spazio in cui si trovano, ci permetterà di capire dove gli stessi oggetti vogliano essere riposti. E non dimenticate che tutti possono raggiungere questo stato mentale.
Nel mio spazio di solito i bisbigli non sono quelli delle cose, anzi sarebbe più corretto non definire bisbigli le esclamazioni ad alta voce su dove esse dovrebbero trovarsi e su dove diavolo siano invece sparite.
Tuttavia lo spazio di sistemazione lo conosco proprio bene, considerato che anche nel disordine la maggior parte delle volte alla fine le cose si trovano!
In ogni caso nulla da obiettare sulla serenità dell’ordine. Non so se corrisponda a un ordine spirituale. Per quello che mi conosco, il mettere ordine è un esercizio che svolgo quando ho finalmente terminato qualche compito gravoso che teneva impegnata la mente. Una volta finito l’onere mentale, è quasi automatico che segua analogamente un’operazione di riordino dello spazio fisico.
Temo però che questo sia il processo inverso di ciò che predica la filosofia buddista.

TartaRugosa ha letto e scritto di: Murakami Haruki (2015), La strana biblioteca, Traduzione di Antonietta Pastore. Illustrato da Lorenzo Ceccotti Einaudi
TartaRugosa ha letto e scritto di:
Murakami Haruki (2015)
La strana biblioteca
Traduzione di Antonietta Pastore
Illustrato da Lorenzo Ceccotti
Einaudi

Il racconto di Murakami Haruki si legge d’un fiato, presi dalla curiosità di inseguire l’intricato percorso che la via della conoscenza può determinare.
Indubbiamente la voglia di sapere del Ragazzo è insolita. Non sa quanto gli costerà questo suo indagare sul sistema di riscossione delle imposte vigente durante l’Impero ottomano.
“Al vecchio brillarono gli occhi … Interessante, molto interessante”.
I libroni che il Vecchio gli consegna possono essere consultati esclusivamente all’interno della biblioteca.
La sala di lettura, confinata al termine di una scala molto lunga, può essere raggiunta dopo una serie di biforcazioni, ora a destra ora a sinistra, che solo il Vecchio conosce.
L’Uomo-pecora che li riceve sa subito cosa rispondere alla domanda del Ragazzo: “Scusi un attimo, signor Uomo-pecora! Non è mica una cella, questa, per caso?. Certo che lo è!, rispose lui.”
Il ragazzo ha solo un mese a disposizione per imparare a memoria quei grossi tomi.
Del Ragazzo sappiamo che è stato ben educato a obbedire, a non rifiutare mai un invito e a gioire delle soddisfazioni altrui; che la sua mamma va in ansia se non lo vede tornare a casa puntuale; che tale ansia è anche determinata dal fatto che il Ragazzo, quando era bambino, è stato morso da un cane molto feroce.
La permanenza in quella cella, però, non assomiglia a una punizione restrittiva.
Portate di cibo delizioso gli vengono fornite da una Ragazzina dolce e bellissima. L’Uomo-pecora che vigila su di lui è severo solo perché teme crudeli punizioni da parte del Vecchio. L’impossibile compito di mandare a memoria quegli enormi tre tomi è in realtà molto accessibile, poiché il Ragazzo diventa lui stesso il collettore delle tasse turco Ibn Armut Hasir.
In una certa misura il soggiorno nella sala di lettura/cella parrebbe fiabesca, non fosse per alcune condizioni date. L’una è che il mondo al di fuori continua e quindi il Ragazzo pensa alla madre preoccupata per il suo mancato rientro e alla possibilità che non dia da mangiare al suo storno.
L’altra, ben più inquietante, è che a missione compiuta, terminato il mese e appreso tutto ciò che i volumi hanno da spiegare, il Vecchio gli segherà la parte superiore del cranio e il suo cervello verrà succhiato.
“- Signor Uomo-pecora, perchè quel vecchio vuole mangiare il mio cervello?
– Perché i cervelli pieni di conoscenze sono squisiti, ecco perché. Sono cremosi. E al tempo stesso granulosi.
– Ma è una cosa mostruosa! Dal punto di vista di chi è succhiato, ovviamente.
– Sì, ma è una cosa che succede in tutte le biblioteche. Più o meno”.
Arriva la notte di luna nuova, quella che “porta via tante cose”.
In quella notte si può tentare la possibilità di fuggire, perché il Ragazzo, la Ragazzina e l’Uomo-pecora desiderano tornare nel mondo.
“La fregatura, con i labirinti, è che soltanto alla fine sai se hai preso la strada giusta. Se scopri che ti sei sbagliato, di solito è troppo tardi per tornare indietro. Questo è il problema con i labirinti”.
Tuttavia l’impresa sembra riuscire, peccato che dopo il tortuoso tragitto a piedi nudi (perché le scarpe nuove scricchiolano troppo) lungo le biforcazioni e le porte che si aprono e si chiudono, ancora una volta si debba transitare dalla stanza 107, proprio là dove tutto era iniziato e dove stavolta non c’è solo il Vecchio, ma anche il feroce cane che ha aggredito il Ragazzo quando era bambino. Il cane, fra i denti, stringe lo storno.
Dopo alcuni colpi di scena, finalmente la fuga è riuscita e il Ragazzo torna a casa.
C’è la madre, c’è la colazione sul tavolo apparecchiato, ma non c’è lo storno e non c’è una richiesta di spiegazioni per la sua sparizione.
Dopo quell’accadimento il Ragazzo non va più alla biblioteca civica.
“Mi succede di pensare a quelle belle scarpe che ho lasciato là sotto. E all’uomo-pecora e alla bellissima ragazza senza voce. Ma è accaduto veramente? In tutta onestà, non posso esserne sicuro, Ciò che so con certezza è che ho perso le mie scarpe e il mio amato storno”.
Quando la mamma muore, il Ragazzo resta proprio solo. Perché non ci sono più la mamma, le scarpe, lo storno, la Ragazza e l’Uomo-pecora: “Quando sono solo, il buio intorno a me si fa molto profondo. Come in una notte di luna nuova”.
Dal buio della profondità della tana, TartaRugosa medita sulle fasi della luna.


TartaRugosa ha letto e scritto di: Pia Pera (2016), Al giardino ancora non l’ho detto, Ponte alle Grazie
TartaRugosa ha letto e scritto di:
Pia Pera (2016)
Al giardino ancora non l’ho detto
Ponte alle Grazie

E’ alle parole di Emily Dickinson che si ispira il titolo di questo libro, l’ultimo di Pia Pera.
” Al giardino ancora non l’ho detto – / non ce la farei. / Nemmeno ho la forza adesso / di confessarlo all’ape. / Non ne farò parola per strada – / le vetrine mi guarderebbero fisso – / che una tanto timida – tanto ignara / abbia l’audacia di morire. / Non devono saperlo le colline – / dove ho tanto vagabondato – / né va detto alle foreste amanti – / il giorno che me ne andrò – /e non lo si sussurri a tavola – / né si accenni sbadati, en passant, / che qualcuno oggi / penetrerà dentro l’Ignoto. ”
La scrittrice, maggiormente conosciuta per i suoi testi sui giardini, in queste pagine prende congedo dalla sua tenuta, nella campagna di Lucca.
Una sorta di diario non-diario: che il tempo scorre lo capisci dalla descrizione delle fioriture, delle messe a dimora di bulbi, rose e cespugli, dalle operazioni dettate dal susseguirsi delle stagioni.
E dai cambiamenti corporei che Pia descrive sia fisicamente, sia attraversando biografie di altre persone che si sono trovate in analoga situazione.
In questo soliloquio a flusso continuo emergono intrecci di varia natura: filosofici, poetici, letterari, autobiografici, tutti improntati alla presa di coscienza della propria finitudine, ma con un’apertura di orizzonte verso lo spazio più amato, il proprio giardino.
“Vale sempre la pena di piantare un giardino, poco importa se di tempo ne resta poco, se tutto vacilla e la morte avanza. Vale sempre la pena di trasformare uno spazio di terra in un posto accogliente, un luogo dove ci sia più vita”.
E’ un monologo denso, che non risparmia al lettore la partecipazione alle perdite narrate, talvolta con lucida razionalità, altre con nostalgia, altre con misto di speranza e investimento nei diversi tipi di cure.
“E’ cresciuta l’empatia. La consapevolezza che, non diversamente da una pianta, io pure subisco i danni delle intemperie, posso seccare, appassire, perdere pezzi, e soprattutto non muovermi come vorrei.
Mi trovo io stessa in balia. Questo ispira un sentimento di fratellanza col giardino, acuisce la sensazione di farne parte. Altrettanto indifesa, altrettanto mortale.
Forse non è così terribile che le forze lentamente scemino. Andarsene bisogna pure in qualche modo. Chi come me vive in solitudine fatica a rendersi conto che arriva il momento di cedere il passo, che la vita è fatta di fasi e non si resta identici fino alla fine”.
Il giardino è vita. Il giardino ha bisogno di cure. Le forze che si assottigliano sono per Pia fonte di preoccupazione, perché dove non c’è più dialogo tra uomo e paesaggio, la natura irrompe e se ne appropria. L’apprensione per il proprio futuro comprende anche la consapevolezza che ci sarà un inevitabile abbandono della manutenzione necessaria e questo tradimento il giardino ancora non lo conosce.
Pure esiste al tempo stesso un rispecchiamento, un desiderio di reciprocità:
“Non sono più il giardiniere. Sono pianta tra le piante, anche di me bisogna prendersi cura. Cosa è cambiato rispetto a prima? Innaffiavo, scavavo, pacciamavo, seminavo, coglievo, rastrellavo, potavo, bruciavo, concimavo, ramavo,tagliavo l’erba. Ora nulla di tutto questo. Passeggio, guardo, valuto, dico cosa fare, ma soprattutto: mi viene preparato da mangiare, mi viene servito a tavola, vengono lavate e stirate le mie cose, vengo accompagnata in auto. Comincio a somigliare sempre più a una pianta di cui bisogna prendersi cura, divento sorella di tutto quanto vive nel giardino, parte di questa sconfinata materia di cui ignoro confini e profondità”.
Lentamente mutano le prospettive:
“La malattia si distingue in questo: impone un’accelerazione a un processo di perdita che, semplicemente invecchiando, resterebbe impercettibile.
Forse questo bisogna fare nel tempo che resta. Non disperderlo in tentativi vani, ma concentrarsi e sfrondare. Più che mai sfrondare. Accettare serenamente la fine”.
Insieme a Pia viviamo momenti bui, le altalene delle remissioni e delle riacutizzazioni, il travaglio della scelta di eterogenei approcci di cura: i farmaci sperimentali, il Qi Gong, l’agopuntura, l’ayurveda, il bombardamento dei vari consigli forniti dalle testimonianze di altri malati sui poteri di improbabili guaritori, la ricerca delle energie elettromagnetiche nocive nel luogo domestico, il tentativo della terapia chelante. Tutto ciò a sua volta associato all’irrompere del sospetto di essere in mano a ciarlatani imbroglioni e alle decisioni prese all’ultimo minuto di sottrarsi o offrirsi a proposte terapeutiche non convenzionali.
Non solo le trasformazioni del corpo, ma della casa, degli spostamenti degli oggetti, dei libri da eliminare, della gioia per l’arrivo della carrozzina.
“Siamo noi a scegliere, di volta in volta, come vivere quanto ci viene dato. Questo imprevisto: a me la scelta tra farne un momento di frustrazione, o uno spiraglio di libera contemplazione nell’ora forse più bella del giorno, sospesa com’è tra il buio e la luce”.
Pur avendo scelto di vivere da sola, Pia riceve spesso visite e confidenze di amici lontani e vicini con cui condividere ricordi di viaggi, riflessioni sul pensiero buddhista, spostamenti verso studi medici, racconti di altre persone che come lei, hanno amato un giardino e a esso hanno dovuto dire addio.
Filosofi, poeti e scrittori lasciano le loro tracce in questo accompagnamento di sé.
Gradualmente, nella sua casa e nella sua terra, fanno comparsa figure di aiuto:“Quanto mi piace dire agli altri cosa devono fare. Ci voleva da ammalarsi, per scoprire quanto dare disposizioni sia in fondo più gratificante di una faticosa autosufficienza”.
Non è un percorso facile. Pia non pensava di morire a sessant’anni e spesso le piaceva immaginarsi vecchia, con le rughe e i capelli bianchi. Quando la malattia irrompe, però, bisogna fare appello a ciò che rimane e a come è possibile sfruttarlo al massimo e quando anche queste ultime capacità si dissolvono, la meditazione aiuta a tenere sotto controllo paura e terrore nel momento più cupo, quello della notte.
La revisione del proprio esistere si ancora alla similitudine delle stagioni:“Sul finire dell’inverno è sempre il mandorlo il primo a fiorire, adesso è il momento del susino. I meli non ancora, i ciliegi non ancora. Non sboccia tutto insieme, così ciascuno si gode il suo momento di gloria,ognuno a turno può esercitare la sua attrattiva ..Mi piacerebbe facessero così anche gli umani, che si accontentassero di primeggiare nel momento del loro massimo fulgore e accettassero poi di restarsene discretamente in disparte”.
Man mano che le possibilità del corpo si restringono, una nuova dimensione si apre:
“Adesso il giardino è il grembo in cui passo questo tempo fisicamente poco attivo in un senso di pace, serenità. E’ quello che vedo dalla finestra, quando sono sdraiata sul divano a leggere. .. Il giardiniere e la morte si configura allora così: il rifugiarsi in un luogo ove morire non sia aspro.
E’ tutto di una bellezza, una grazia, un’armonia, che mi sorprendo a desiderare di vedere un’altra primavera ancora, e a pensare: che strano che adesso che ne dubito, che non lo do per scontato, il mondo mi appaia incredibilmente ricco di meraviglie”.
Il 26 luglio 2016 Pia se ne va.
TartaRugosa, nel suo giardino, aveva da poco finito di leggere quelle che sono diventate le sue memorie.
TartaRugosa ha letto e scritto di: ANDREA BAJANI (2016), Un bene al mondo Einaudi, Torino
TartaRugosa ha letto e scritto di:
Andrea Bajani (2016)
Un bene al mondo
Einaudi, Torino

Se qualcuno ti chiedesse di dare un volto al dolore, o di descriverne l’odore, o di raccontare la sua forma, o di definirne il colore, che cosa sceglieresti con una sola parola?
E’ una domanda che mi sono posta rincorsa da migliaia di parole sparse nell’aria, non sempre sicure della loro destinazione, ma soltanto vogliose di essere dette. Perché, come scrive Bajani, “una parola, se non ha nessuno a cui dire una cosa, smette di vivere”.
Sul dolore molto si narra, con rabbia, con inquietudine, con disperazione, con frenesia, con disillusione, con saggezza, con ricordo e volontà.
Nell’esperienza personale, tuttavia, mentre si convive con esso in tempo reale, si fa una certa fatica a essere accoglienti e riconoscenti nei suoi confronti.
Il dolore è quella roba dal cui abbraccio vorresti scioglierti e al cui strazio sottrarti. Invano.
Bajani prova invece a guardarlo direttamente, dandogli un’identità ben precisa perché, anche se tu non lo sai, il dolore può già venirti a trovare quando sei nella culla, “la mamma era un’ombra grande distesa su un letto, il dolore un’ombra più piccola che lui cercava di mettere a fuoco. Il dolore gli faceva solletico ai piedi, e il bambino apriva la bocca e rideva”.
Ecco quindi che il dolore diventa un compagno di vita fedele, è felice di starti accanto, conosce tutto di te, ti ama e ti protegge.
Il dolore,qui, nel bambino, simbolicamente assume la forma del cane. “Il dolore si porta a passeggio nei boschi, cosicché possa incontrare altri dolori, annusarli, riconoscerli e scodinzolare, oppure evitarli perché troppo ringhiosi”.
Questo l’esordio:
“C’era un bambino che aveva un dolore da cui non voleva mai separarsi. Se lo portava dappertutto, ci attraversava il paese per andare a scuola tutte le mattine. Quando arrivava in classe, il dolore si accucciava ai suoi piedi e per cinque ore se ne stava senza fiatare … Quando arrivava a casa … stendeva una tovaglia sul tavolo e mangiava. Il dolore montava sulla sedia accanto, e mentre mangiava, il bambino lo accarezzava. Quando c’erano i genitori, invece , il dolore stava tra i piedi del suo padrone. Di tanto in tanto, il bambino faceva sparire la mano sotto il tavolo e gli offriva un pezzo di pane. Il dolore avvicinava il muso alla mano, e dopo gli leccava le dita”.
Il dolore del bambino ci appare un dolore docile, morbido, quieto.
Ma c’è anche il dolore grosso del padre che “difficilmente riusciva a tenerlo al guinzaglio. Perciò spesso si liberava con uno strappo e aggrediva chiunque gli passasse vicino. Apriva le fauci, latrava e dopo si sentiva l’urlo di chi era stato colpito”.
La violenza esiste. Esiste il male. Entrambi talvolta possono essere immaginati altrove, anche se troppo spesso si assopiscono dentro le pareti di casa.
“Il paese dove vivevano il bambino, il suo dolore e i suoi genitori era un posto che non stava da nessuna parte … era tagliato in due dai binari del treno … Oltre i binari ci andava solo la polizia. Là abitavano dolori anche più feroci. Il bambino andava oltre i binari. Nonostante facesse paura a tutti, al bambino quel mondo sembrava abitato solo da persone gentili”.
Forse perché là, oltre i binari, abita anche la bambina sottile col suo dolore piccolo e spelacchiato che però quando esce lascia dall’altra parte della ferrovia, perché tanto sa che l’avrebbe subito ritrovato al ritorno.
Ma quello sarebbe stato il loro segreto e ogni volta il bambino non dice niente a nessuno “perché un segreto mostrato a tante persone è un segreto che muore”.
E proprio là, dove c’è la ferrovia con il cartello blu della stazione con scritto il nome del paese, era bello poter pensare che “un giorno sarebbero stati lì ad aspettare, pronti a partire. Sarebbero andati anche loro oltre il confine, anche se di quello che c’era dopo non sapevano niente”.
In quel luogo, nell’illusione, prendono forma le lettere mai scritte alla bambina sottile, per acchiappare con lei il sogno di salire sul treno e varcare il confine. Lì, in quelle lettere scritte solo col pensiero “il dolore era più allegro, e tutti e due gli occhi sorridevano quando il treno sfrecciava”
Nella storia del bambino, anche il dolore feroce si può addomesticare. Quello del padre era molto grosso, per questo lo affida al figlio, visto che è così bravo con il proprio. Così il bambino aggancia il collare al suo guinzaglio e lo porta fuori.
“I dolori del padre e del figlio per la prima volta giocarono insieme. Il dolore del padre era maldestro e forse era la prima volta che giocava davvero. Si alzava di poco da terra e subito ricadeva più pesante e affannato. Eppure alla fine il beneficio fu grande. Correre dietro gli uccelli, inseguire le farfalle che fingevano di essere foglie, fece venire al dolore del padre un muso più mite”.
Il dolore qualche volta scappa, cerca un’altra strada, un’altra casa da abitare, ma è complicato accettare la separazione: “Per molto tempo il dolore non si fece vedere, ma non abbandonò mai il suo padrone. Perché se è vero che il bambino non poteva vivere senza il suo dolore, era vero anche l’inverso: senza il bambino il dolore era un’ombra che girava per strada. .. Per questo, e nonostante ciò era successo, il dolore non avrebbe mai lasciato il bambino. Lo seguiva da lontano quando lo vedeva camminare in paese, e ogni sera dormiva sotto il suo balcone”.
Come tutti i dolori, anche il dolore del padre ha bisogno del suo vero padrone e quando il bambino glielo restituisce per uscire di casa, quando rientra trova una cosa brutta: “una signora disse che doveva farsi coraggio perché dentro c’era la polizia …Il poliziotto gli spiegò che non era successo niente di irreparabile. Era soltanto il dolore del padre che aveva avuto una crisi… disse di stare tranquillo perché avevano chiuso il padre e il suo dolore dentro una stanza”.
Cosa può fare il bambino se non diventare conchiglia in fondo all’abisso e aspettare?
“Quella notte …trattenne il respiro e saltò … e scivolò fino in fondo all’abisso … prese la conchiglia tra le dita … Tornò verso la superficie lasciandosi trasportare…Sfondò il mare con un respiro che si spalancò e gli sembrò di respirare tutto il cielo … Di fronte c’era la casa … e tutto fu come era sempre stato, e tutto fu di nuovo per la prima volta”.
Ci si potrebbe domandare come va a finire questa storia.
Cosa ne è del bambino, del suo viaggio che va oltre il confine.
Cosa ne è della bambina sottile che rimane nel paese, oltre la ferrovia.
Cosa ne è delle parole disordinate che volano in una tormenta di suoni, in infinite lettere iniziate con un “caro” e una “cara”.
Cosa ne è del loro amore, delle loro paure, dei loro fedeli dolori.
Cosa ne è del fatto che non sono più bambini, ma adulti.
Ma nelle vie della città che è una qualsiasi città e del paese che non si sa dove sia, pure appaiono le stesse cose di sempre: le piazze, le chiese, le scuole, i negozi, i cimiteri, le stazioni.
Dentro quelle stazioni arrivano e partono treni e dentro i treni persone salgono e scendono, ma nella loro solitudine non sono mai veramente soli, perché il dolore sempre li accompagna tutti.
Qualche volta si allontana, ma poi ritorna perché ha bisogno di qualcuno che si occupi sul serio di lui.
Come la lettura delle parole scivolate nelle pagine di questo libro che, in un tempo senza tempo e in uno spazio senza spazio, a volte un po’ distanti, a volte appiccicate addosso, chiedono di essere abbracciate e amate perché vivono in ognuno di noi.