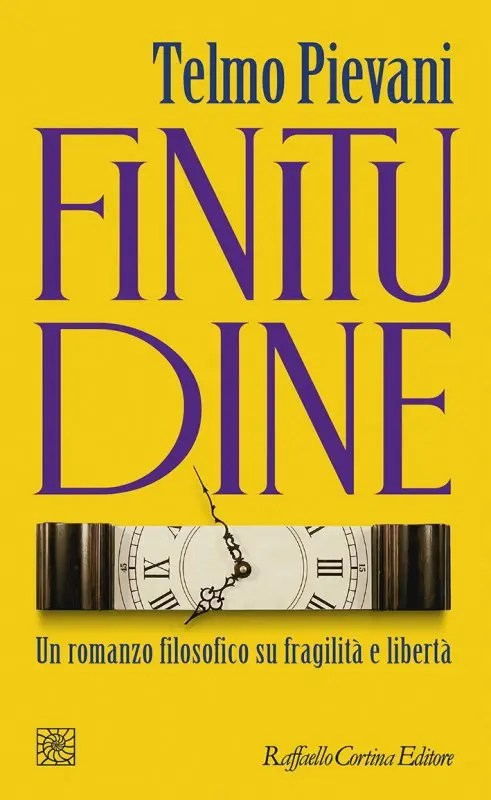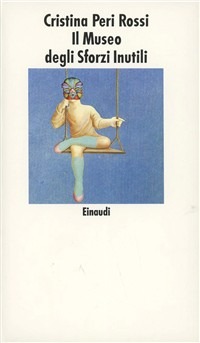Il filo rosso di questo romanzo è il tema della cura. Un modello di cura insolito, tutto proteso al soddisfacimento totale dei bisogni del Bambino, fino ad arrivare al parossismo e all’annullamento dei progetti di vita di una coppia poco più che adolescente.
Pietro e Anna, infatti, si conoscono da giovani, il primo figlio unico di una coppia di avvocati, apparteneva alla schiera degli studenti fuori corso in medicina … Agli occhi dei genitori sembrava fermo in una adolescenza senza tramonto. Gli piacevano le automobili e le ragazze, e coltivava queste fascinazioni come se fossero categorie dello spirito, pur riuscendo a non farsene ossessionare.
Anna, invece, magrissima, appariscente più che bella, tanto intelligente quanto brillante, coniugava slanci di generosità a cambiamenti di umore improvvisi.
Nessuna delle loro due famiglie, distanti anche territorialmente avrebbe scommesso sulla durata di una relazione fatta di continui litigi e men che meno sulla possibilità di un matrimonio, convinzione disattesa da un inaspettato evento: Anna rimane incinta.
Quell’evento fu l’inizio della fine ma anche la fine dell’inizio, perché Angelo mandò all’aria ogni progetto.
Angelino irrompe sulla scena con tutto il suo bagaglio di imperfezioni e patologie destinate ad aggravarsi col trascorrere del tempo e trasformando la routine della coppia in una serie di rituali ossessivi da seguire secondo una cadenza dettata non dall’orario, ma dalle perturbazioni psichiche di quel Bambino il cui appellativo sarà sempre un vezzeggiativo cui riferirsi anche nell’età adulta e relative modificazioni corporee.
Angelo fu il frutto scemo di un’idrocefalia che già nel grembo della madre gli aveva lesionato il cervello, scavando un sentiero di undici centimetri. Undici centimetri di materia grigia graffiata, di potenzialità soffiate via dalla negligenze e dal caso, intrecciati in un balletto che in apparenza non possedeva alcuna armonia…. se gli fosse stata diagnosticata in tempo quell’idrocefalia avrebbe anche potuto mettere le basi per un percorso terapeutico in grado di traghettarlo verso una faticosa normalità.
Ciò che stride e sconcerta in questa abnegazione di cura dedita al Bambino è proprio il rifiuto della coppia di ricorrere a servizi di supporto riabilitativi orientati a sollecitare dai primissimi mesi di vita capacità latenti o residue. Una fissità ostinata e caparbia, mai comunicata esplicitamente, ma che diventa un copione sottoscritto da ambedue i genitori, incuranti di suggerimenti e sprone di chi non si accontenta di commiserare la vicenda.
Angelino ai loro occhi appariva senza macchia, uno degli eletti che avrebbero ereditato il regno dei cieli. Pur senza confessarselo, entrambi finirono per credere che un istituto di riabilitazione avrebbe rappresentato un luogo di esilio, un modo per tenere il loro figlio lontano dal mondo dei normali, e questo era inaccettabile.
Pagarono un prezzo personale altissimo, ma decisero di serrare tutte le potenzialità di Angelo in una vita protetta, assecondandone gli umori, i bisogni, le debolezze e i capricci come fossero due re senza corona, sottoposti a una volontà più grande della loro.
I problemi sono evidenti da subito e il personale sanitario,(di prestigio e ricercato anche all’estero in una sorta di costosissimo viaggio della speranza) si prodiga a diagnosticare, istruire, allertare, suggerire. I bisogni primari diventano una sfida per far fronte alla mera sopravvivenza e ogni scelta viene esercitata con l’esclusivo obiettivo di non lasciare mancare nulla al Bambino, pur nella consapevolezza di essere spesso vittime di speculazioni e raggiri.
Per l’alimentazione non mancherà mai l’acquisto di cibi di primissima qualità che diventeranno
… una specie di pappa grigiastra dal sapore incerto, servita sempre grazie a enormi cucchiai di metallo, con cui venne imboccato fino quasi alla fine dei suoi giorni. …
E poiché per tutta la vita il Bambino non riuscirà a comunicare la necessità di andare in bagno, i genitori si vedranno costretti a farlo vivere imbracato prima nei pannolini e poi nei pannoloni.
Un ulteriore accidente legato a un’anomala reazione a un vaccino, obbligherà pure ad acquistare una signorile casa con una stanza da bagno regale, considerato che il Bambino è estasiato dall’acqua, ma nella subentrata condizione fisica dovrà evitare il mare e l’esposizione solare.
La stanza da bagno divenne la nuova iniziativa terapeutica per soddisfare il suo amore per l’acqua.
Quell’ambiente divenne il suo regno. Vi entrava accompagnato dalla madre e dalle domestiche subito dopo aver fatto colazione, intorno alle cinque di pomeriggio, per uscirne solo due o tre ore più tardi, a seconda dell’umore.
L’unica concessione a se stessi, consci dall’impossibilità di occuparsi da soli delle ingombranti voglie del figlio, è l’arrivo di Nora e Roselyn, due sorelle filippine, che immediatamente
furono allettate e sedotte dal richiamo del bisogno….Angelino divenne presto ragione di vita assai più potente di uno stipendio in volo verso casa.
E’ soprattutto Pietro il genitore maggiormente coinvolto, anche fisicamente, nella cura di Angelo. Quando il corpo del Bambino crescerà, a dispetto della gravità della patologia, la robustezza e la caparbietà diventeranno ancora più evidenti, accompagnate da fenomeni di autolesionismo così accanite che causeranno cecità.
Nei periodi peggiori l’impulso a colpirsi scattava circa una volta ogni due o tre minuti, quindi non meno di trecento al giorno a esclusione delle ore di sonno. … A quel punto si decise che a turno un membro della famiglia dovesse stargli vicino per tenergli le mani ed evitare che si colpisse. Fu l’inizio di un braccio di ferro che durò per decenni.
La scoperta di un effetto tranquillante determinato da spostamenti in auto e passeggiatine notturne costituirà un ulteriore stravolgimento della vita, perché la pratica della ripetizione s’impossessò anche di quelle nuove attività.
Riecco l’esasperante compulsione:
Tra la possibilità di migliorare il presente e la ripetizione ossessiva, la famiglia scelse sempre la seconda strada.
Nel racconto si inserisce a un certo punto un nuovo personaggio: Lorenzo Riccardi, la cui storia si svela in una serie di pagine che offre uno spaccato del carattere del ragazzo, le sue origini, le sue incertezze e il desiderio di essere altro da sé. Lorenzo diventerà l’autista delle scorribande di Angelo e, come Nora e Roselyn subirà l’identica fascinazione verso il Bambino-Mostro e il suo destino. Lo capiremo quando Angelo, ormai cinquantenne, non potrà più contare sulla presenza genitoriale, annientata dalla malattia e dalla morte.
Se l’universo del Bambino è costellato dall’incoscienza e dalla perenne aspettativa di vedere esaudita ogni sua richiesta, per i genitori la vita scorre inesorabilmente verso l’invecchiamento. Anna sarà la prima ad andarsene. Pietro rimarrà cardiopatico e funestato dall’intero prosciugamento dei beni finanziari, sperperati non per indulgere in lussi o vizi (qualche scappatella sentimentale, tollerata da Anna, resterà nel campo delle probabilità, data la priorità dei bisogni del figlio), ma per concedere tutto, ma proprio tutto, al benessere di Angelo.
Il “dopo di noi” tanto allarmante per ogni coppia genitoriale che accudisce un figlio disabile diventa la nuova realtà per il futuro di Angelo.
Pietro e Anna non si erano mai concessi il lusso dell’ammissione dell’impotenza, della stanchezza paralizzante, neppure la voglia di rivendicarne la malasorte. Quasi subito entrambi intuirono come il Bambino potesse essere un’opportunità che li avrebbe tenuti insieme per sempre, che li avrebbe condotti non verso la gioia piena, ma sulla stessa rotta.
Sarà sufficiente il medesimo, disinteressato amore di Nora, Roselyn e Lorenzo a garantire al Bambino un modello di cura familiare senza ricorrere al presagio del ricovero in una struttura d’avanguardia e costosa che continui risolutamente quell’assistenza cui il Bambino si è abituato?
Un romanzo asciutto e duro che, tuttavia, propone uno sguardo del Diverso da una prospettiva, se pur non condivisibile, centrata sul principio di restituzione del processo di cura:
Angelo Bonaventura, in fondo, era stato un mostro generoso. Un ciclope bambino che aveva divorato la vita di Pietro e Anna per restituirgliela più completa e matura.