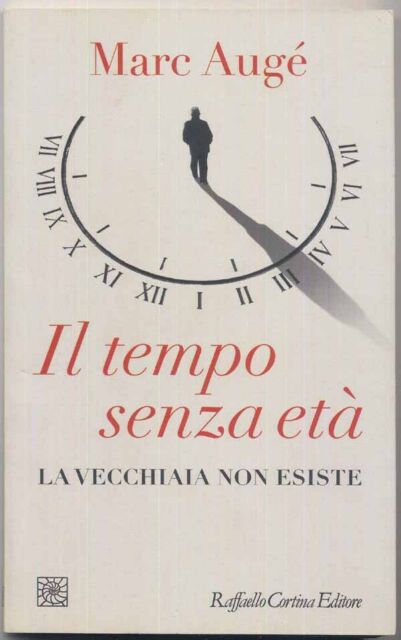L’autore, chiuso nella stretta dell’isolamento causato dalla pandemia, di notte esce e nel cammino lungo le strade deserte si sofferma a osservare gli alberi. Ne scopre la voce, il pensiero, la potenza comunicativa.
Parla agli alberi per parlare a se stesso, intrattiene dialoghi, interroga, risponde, instaura un sodalizio basato sul reciproco ascolto e in questi suoi intrattenimenti intersoggettivi con la vita arborea scopre le differenze tra essere umano ed essere vegetale, in un alternarsi continuo di flussi di coscienza, poesia, fantasia e sogni.
L’attenzione è rivolta soprattutto agli alberi murati, ritenuti così simili agli uomini murati di tutto il mondo a causa di un infinitesimo virus, e Moresco rimane folgorato dalla sapienza con cui queste creature sanno strappare la vita là dove trovano improbabili pertugi per nascere, negli spazi dove il vento ha deposto il loro seme.
… ci sono quelli i cui semi attecchiscono nei muri, negli interstizi tra un mattone e l’altro o tra una pietra e l’altra, dentro la calce; ci sono quelli ridotti quasi alla sola corteccia, riempiti di mattoni e cemento nelle loro cavità e che però la primavera continuano a coprirsi di nuove foglie; ci sono quelli che si incuneano con le loro radici nell’asfalto dei marciapiedi e che lo sollevano e squarciano con le loro dure vene nere, tanto che devi camminarci sopra sollevando molto i piedi e le gambe e allargando le braccia come un equilibrista sul filo. … Da quando ho cominciato a osservare gli alberi murati ne ho visti scaturire con la loro silenziosa e inarrestabile spinta dalle superfici più impensate. Ne ho visti erompere da vecchie edicole di giornali chiuse da tempo … dai comignoli di case abbandonate … dai cartelli stradali … dalle zone industriali dismesse … dalle pompe di benzina con le colonnine sfondate … dalle ruote abbandonate delle macchine … dai varchi delle finestre delle case abbandonate … dalle massicciate delle ferrovie … dai cimiteri di macchine … dalle fessure e crepe di statue su cui il vento aveva trasportato per caso i loro semi.
L’albero murato diventa così una specie a se stante, qualcosa che insegna all’essere umano nuovi modi per misurarsi con i limiti, qualcosa che sa indicare una strada per superarli senza la bussola di una macchina centrale cerebrale.
“Che cos’è il cervello?”
“Come faccio a spiegarti … è la centrale del corpo”
“Ah sì? E se si blocca quello si blocca tutto?”
“Più o meno”
“Come siete fatti male!”
Loro, gli alberi, si parlano e conoscono tutto ciò che avviene nel mondo umano grazie alle infinite connessioni tra ogni singola parte della loro struttura, che viaggi nel buio del sottosuolo o si protenda verso la vastità della luce: radici, tronco, rami, foglie, midollo.
“La nostra sapienza è una cosa sola con noi, con le nostre radici, i nostri rami, le nostre foglie, fa un tutt’uno con i nostri corpi e si modifica e cresce con loro, mentre quella che state costruendo voi è tutta fuori di voi e vi sta oltrepassando”.
E ancora, ascoltando la voce degli alberi, si impara come il mondo vegetale guarda agli uomini e come leggono la loro storia.
“Per noi alberi voi umani siete tutti piccoli, brutti e deformi. … Ma come fate a essere così piccoli, così brutti e così deformi e nello stesso tempo a credervi i più grandi, i più belli e persino i più intelligenti e i padroni assoluti del mondo e dell’universo?”
E poi c’è il magico incontro col tiglio:
Una delle macchine parcheggiate ha una portiera aperta, quella dalla parte del posto di guida. Mi avvicino, faccio per chiuderla, e allora mi accorgo che la chiave è ancora inserita nel cruscotto. … Però c’è qualcosa di strano davanti all’altro sedile … qualcosa di sottile che sale dal tappetino e che arriva fino al cruscotto e anche oltre, fino al parabrezza. …”e tu chi sei?” “sono un tiglio” mi risponde una vocina” “Come ha fatto il tuo seme ad attecchire su quel tappetino di gomma?” “Perché sopra c’era un po’ di terra, che si è staccata dalla suola delle scarpe di chi saliva. E a me è bastato”.
Ma non è quello il suo posto: è giunta l’ora di partire e di raggiungere i suoi simili. Dopo tanto gridare è arrivato qualcuno che ha sentito la sua voce e lo conduce dove la piantina esige: “Voglio andare finalmente dentro la terra, con le mie radici, con la mia vita!”.
In un crescendo di intensità incontriamo così tre cori.
Il coro degli alberi che canta:
“Noi sappiamo tutto di voi, sappiamo anche quello che voi non sapete, non volete sapere. … Vi siete inventati un’essenza separata che avete chiamato anima solo per poter dire, pensare e delirare che solo voi ce l’avevate mentre tutti gli altri ne erano privi e quindi potevano essere sterminati, maciullati, annientati e sacrificati sull’altare della vostra folle specie.”
“Che mondo è questo? Le nostre radici si dicevano l’un l’altra, sbalordite, continuando a correre sottoterra e incrociandosi con mille altre radici. Che pensiero è questo? Che specie è questa? Ne abbiamo viste tante passare, ma mai una specie spaventata, disperata e folle come questa.”
Il coro degli alberi capovolti, invece, una distesa di radici attorcigliate e di fili frementi e di nodi che si stagliano contro il cielo, indica una possibile strada (compresa la fatica per costruirla) per intravvedere un mutamento, una mutazione, che non si sa mai da che parte inizia, ma che pure qualcuno a un certo punto la sollecita, iniziando ad assumere la posizione all’ingiù.
Occorre cambiare gioco:
“Dovrebbero cominciare a formarsi nuove, sperimentali e diffuse sinapsi, nuove visioni e nuovi sogni, dovrebbero formarsi nuove possibilità umane e postumane impensate, che forse si stanno già formando, chi può dire, perché quando si formano nessuno riesce per un po’ o per molto ad avvistarle, nessuno se ne accorge, se ne può o se ne vuole accorgere, urgono irresistibilmente dal basso e nessuno le sente, come le radici che crescono in silenzio sotto terra o murate vive, quelle bianche, quelle nere, quelle di fuoco e anche quelle musicali.
Se noi non ci fossimo capovolti e non avessimo cominciato questo inconcepibile viaggio senza speranza non avremmo mai immaginato che dietro il cielo potesse esserci un altro cielo, che dietro la luce potesse esserci un’altra luce, che si potesse trovare e inventare un altro cielo al di là della terra e un’altra terra al di là del cielo … E allora, forse, anche gli umani, assistendo a questo sconvolgente e inarrestabile riposizionamento vegetale, … allora, forse, anche le loro teste e i loro cervelli, invece di galleggiare nell’aria, cominceranno a radicarsi poco per volta dentro la terra e a mettere radici là dentro … E allora, forse, anche loro capovolgeranno se stessi e la loro vita e capovolgeranno il mondo, cominceranno a muoversi in un mondo capovolto mai visto prima, che era sotto i loro occhi ma che non vedevano”.
Il terzo coro, quello degli alberi musicali ci accompagna alla metamorfosi finale, la più complessa perché non può mai essere programmata, ma la si costruisce a poco a poco mescolando la realtà, l’immaginazione e il sogno.
E’ il regno della poesia, del canto, della musica che non può essere annientato, ma va custodito e tramandato per sognare il nuovo sogno, il salto di specie.
“E così ci siamo separati dagli altri alberi silenziosi, ci siamo dovuti separare per non farci immobilizzare, per poter continuare a sognare che a poco a poco anche tutti gli altri alberi diventeranno musicali … che tutto il nostro pianeta diventerà un pianeta musicale, che la sua musica potrà tracimare oltre la sua stessa atmosfera .. e forse persino voi, se riuscirete a tracimare da voi stessi e ad andare verso un’invenzione di specie … allora ci verremo incontro alla fine del tempo e all’inizio del tempo, nel tempo che c’è al di là del tempo e allora ci riconosceremo e ci abbracceremo e ci proietteremo e ci inventeremo …”
Non sono altrettanto sognanti le riflessioni finali di Moresco che, all’epoca della stesura del libro, riportava un bilancio di 33.000 morti nel nostro Paese e il timore di un ritorno alla normalità senza cambiare niente, senza inventare niente.
Oggi gli umani stanno sognando la fine guardando un’altra volta al di fuori di sé, al vaccino. La visione interiore, la metamorfosi, pare una strada ancora lontana.
I morti sinora sono 61.240.