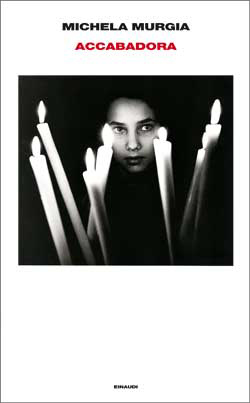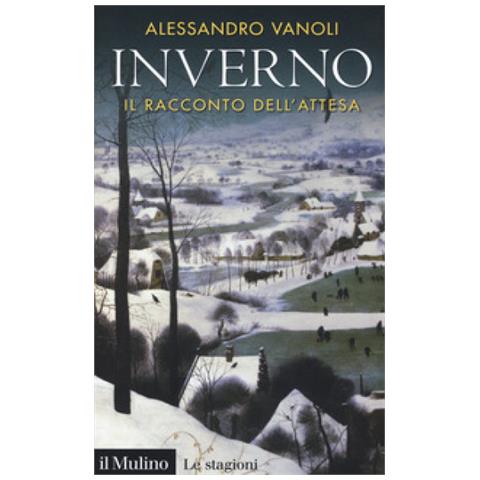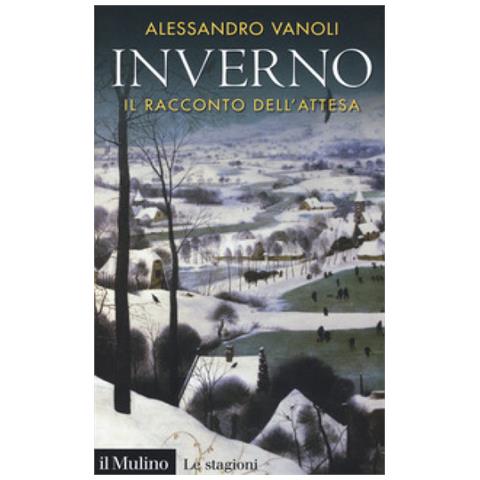I miei giri diventano sempre più circoscritti.
La zona della tana è già stata individuata e non mi fido a lasciare incustodito per troppo tempo quell’invitante giaciglio intiepidito dai raggi pomeridiani di un settembre generoso di luce e calore.
Nonostante la mitezza della temperatura e l’abbondante vegetazione colorata dai frutti maturi, sento l’avvicinarsi del tempo del silenzio e del riposo. Cerco le parole custodi del mio scivolare nel sonno in una scrittura densa, struggente, nostalgica, così vicina allo stato d’animo scatenato dal necessario temporaneo congedo dal luogo che amo.
Terracarne è già un titolo che fa intuire la comunione totale del corpo con la terra, e questo annuncio solletica l’attesa del lungo abbraccio che mi cullerà nei prossimi mesi. Nell’imminente immobilità causata dal freddo del Nord, un libro che parla di spostamenti intorno ai paesi invisibili e ai paesi giganti del Sud dell’Italia è una tentazione cui non so resistere, pungolata dalla visione della mappatura geografica che orienta il mio andare e dalla certezza che questo viaggio sia in realtà perno su cui avvolgere pensieri e riflessioni sulla ricerca proprio di quei luoghi che sempre inseguono i nostri sogni infranti.
Franco Arminio cerca di tratteggiare lo spirito del suo vagare con lo splendido termine di paesologo, una professione conosciuta a ben pochi e che trova nelle sue pagine sfumature di definizioni appena delineate: “La paesologia è semplicemente la scrittura che viene dopo aver bagnato il corpo nella luce di un luogo … Il paesologo va nei paesi a pescare lo sconforto e si ritrova tra le mani un poco di beatitudine: può essere uno scalino, una casa nuova o antica, può essere la visione di un castello o di un albero di noci, può essere una piazza vuota o un vicolo col ronzio di un televisore. Si va nei luoghi più sperduti e affranti e si trova qualcosa, ci si riempie perché il mondo ha più senso dov’è più vuoto, il mondo è sopportabile solo nelle sue fessure, negli spazi trascurati, nei luoghi dove il rullo del consumare e del produrre ha trovato qualche sasso che non si lascia sbriciolare … non basta attraversare un luogo, ci vuole che il luogo ti attraversi”.
Che cosa cerca Arminio in questo suo interminabile transitare tra i paesi del Sud? Un Sud che scopriamo a intermittenza congelato tra il ricordo di una geografia originaria disegnata dal moto perpetuo e lo scontro con l’insulto di un divenire ributtante, perché di quella terra nulla rispetta. Il ritratto paesaggistico del Mezzogiorno d’Italia è di un realismo spietato, ma la voce narrante è quella di un poeta che sa come guidarci fra terre ancora intatte nella loro primigenia bellezza per poi scaraventarci analogamente negli scempi della cosiddetta modernità, basata sul più bieco sfruttamento della cultura locale.
Non esistono mezzi termini nel suo citare Salvemini: “Cento anni fa Gaetano Salvemini scriveva: Nel Mezzogiorno d’Italia la potenza sociale, politica, morale della piccola borghesia intellettuale è assai più grande e più malefica che nel Nord. … Essi non vedono nella vita se non un gioco di protezioni, uno scontrarsi di influenze più o meno efficaci, un prevalere di simpatie o antipatie capricciose. Per essi non esiste alcuna scala di valori morali obiettivi. Il merito consiste nell’avere un protettore potente. Sarebbero capaci di presentarsi innanzi a un possibile patrono in ginocchio, strisciando la lingua per terra”.
E allora dove si spinge la ricerca, se poi alla fine non è la politica, il progresso, la ricostruzione, ma la gente stessa artefice delle proprie rovine? “L’Irpinia che è venuta dopo il terremoto, quella che c’è adesso, è una terra stuprata in molti punti, una terra che a viverci dentro ogni giorno ti dà tanto dolore, ma pure un soffio incerto di lietezza. Non starò a dire ancora una volta degli errori e degli orrori della ricostruzione, del grande abbaglio di portare le industrie in montagna, dell’illusione che fare tante case avrebbe dato più vita ai paesi. …Le colpe delle classi dirigenti di allora, che poi sono le stesse di adesso, sono evidenti. Non si possono tacere, tuttavia, anche le colpe di gran parte della popolazione, che fu tanto ansiosa allora di partecipare alla spartizione del bottino. … Nuovi sono gli intonaci, le vernici, ma il malanimo di questa terra è ancora qui, la diffidenza e il rancore restano il nostro marchio di fabbrica, unitamente al vittimismo e all’accidia.”
Arminio sa qual è l’affanno della sua rincorsa: “Il Sud che cerco è annidato nei paesi più sperduti, il Sud che resiste dove c’è poca gente, dove ci sono alberi, erbacce, cardi, il Sud che vive ancora solo dove è più dimesso, il Sud che non crede alla pagliacciata del progresso, il Sud dei cani randagi, dei vecchi seduti sulle scale, delle case di pietra incollate in lunghe fila che si attorcigliano. Il Sud che amo ha più di ottant’anni e rughe non lisciate, è una tribù di reumi e bastoni, è ugualmente lontano dall’Europa e dall’Africa, è una terra di magie arrangiate, di cimiteri sempre ampliati, di piazze livide e rancorose. Io voglio frugare tutta la vita in questo Sud fino a quando scompare, voglio restare tutta la vita dentro i suoi paesi rotti e malandati. Sono un guardiano della più solitaria disperazione. Sono vivo nei paesi invernali quando passa un funerale, sono vivo quando nevica e nei giorni più ventosi, nelle case dove i ragni fanno i nidi nelle damigiane, nel bar degli scapoli…. L’Italia che amo è quella che non sa niente di sé, che non si sente ricca né povera, che non si vanta e non si lamenta, un’Italia che appare a lampi su strade periferiche, un’Italia rimasta viva per sbaglio, per le amnesie della politica, per i mancamenti del progresso”.
E’ l’affanno di svelare un genius loci imbavagliato, impaurito, offuscato da strati di finta civilizzazione: “Mi sembra che il mondo lo abbiamo svuotato a furia di riempirlo. Mi sembra che le nostre giornate siano una trafila affannosa nella scontentezza. Siamo scontenti nel tempo libero e quando lavoriamo, siamo scontenti quando il nostro amore è corrisposto e anche quando non lo è. Siamo scontenti quando gli altri ci ignorano e quando si occupano di noi. Forse il problema sta nel fatto che siamo troppi. Forse la vita ha un suo tetto di intensità prestabilito. La felicità che si poteva spartire un milione di uomini è la stessa che adesso si debbono spartire un miliardo di uomini. Il nostro sfiatamento sta tutto nell’aver invaso il pianeta con la nostra presenza”.
Mentre leggo tremo e scavo. Esagerato dire che lo faccio per orgoglio, per rivoluzione, per utopia o, forse, per paura. Semplicemente scavo per sentire la terra che diventa parte di me ed io parte di lei, condividendone, per il periodo del sonno, lo spazio dello stesso punto di vista di un paesaggio perduto.
“La società è basata su un diluvio di bugie, si rimane insieme per diplomazia. I luoghi non ci corrispondono e noi non corrispondiamo ai luoghi, le vicinanze sono sempre precarie, un colpo di vento le fa saltare. Si parla tanto di comunità, ma a malapena riusciamo a contenerci in noi stessi. … Solo quando il filo si spezza ci accorgiamo che in fondo qualcosa di quello che stiamo facendo ha un senso. Ci accorgiamo che il segreto è il semplice stare da qualche parte, con quello che c’è, perché è sempre tanto, una collina, un albero. Tendiamo a posare su tutto i teloni dell’abitudine, però un colpo secco a volte viene da sotto e ci scompiglia, e allora vediamo che tutto è appoggiato provvisoriamente sulla tavola del mondo. …Bisogna soffiare nelle nostre visioni come se fossero piume. E così pure nella nostra carne. Io vivo così, a metà tra me stesso e il paesaggio, vivo nel mio respiro e nel respiro della terra.”